Intervista a Orecchio Acerbo: identità di un editore
13 Febbraio, 2011Intervista a Fausta Orecchio, editrice di orecchio acerbo, di Anna Castagnoli
.
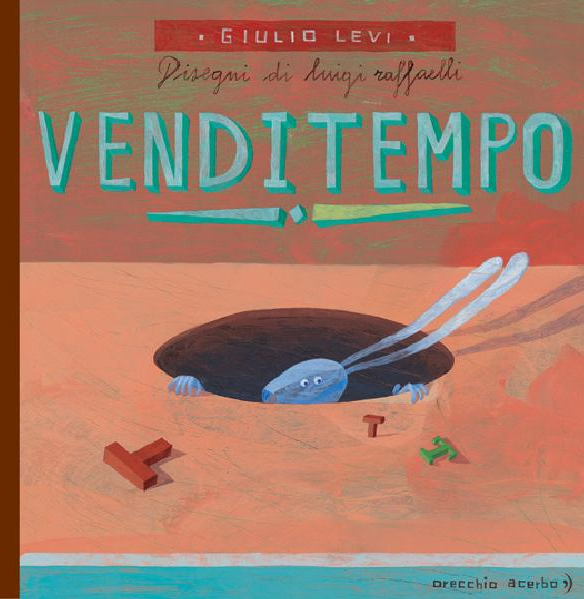
Giulio Levi e Luigi Raffaelli, Venditempo, orecchio acerbo 2010
Perché editori e perché editori per bambini.
Noi siamo grafici, molto prima -e probabilmente meglio- che editori. Abbiamo deciso di dar vita alla casa editrice perché da qualche anno non riuscivamo più a fare âbuona graficaâ. Nelle case editrici per cui lavoravamo allora (parlo del 2001), già da qualche tempo avanzavano a passi da gigante gli uffici marketing. Le scelte erano sempre più squilibrate su un presunto criterio di vendibilità piuttosto che sulla qualità . E poi era da tempo che ci sarebbe piaciuto affrontare, come grafici, il libro illustrato. Allora, in Italia, di picture book non câera traccia. E così, nel â99, quando lo studio grafico ha preso il nome di âorecchio acerboâ ânome decisamente profeticoâ abbiamo messo nello statuto la possibilità di pubblicare libri. Il primo libro è stato pubblicato dopo circa due anni, quasi per caso. In occasione di âuno + uno fa unoâ, una mostra dedicata ai lavori fatti insieme con Fabian Negrin, abbiamo deciso di pubblicare un libro prodotto da noi: âIl Gigante Gampibiomboâ. Era il 6 dicembre 2001 quando uscì quel libro e fu diffuso in pochissime librerie, quelle che con un lavoro davvero faticoso, eravamo riusciti a contattare. Non avevamo le idee chiare sul futuro, ma fin dal primo momento ci rendemmo conto che cominciava una storia molto seria, che avrebbe cambiato non poco le nostre vite. Quello che vedevamo nei libri per ragazzi era sconfortante: buoni testi accostati a pessime illustrazioni, bravi illustratori costretti a lavorare su testi banali o ad andare via dallâItalia. E la grafica? Se si sentiva, il più delle volte era per i danni che faceva.
In sintesi: volevamo far bene il nostro lavoro, amavamo i libri illustrati e quello che câera in Italia non ci piaceva. Siamo stati molto ostinati nel non ascoltare alcun consiglio degli âaddetti ai lavoriâ, anche di fronte ai moltissimi errori che commettevamo. Volevamo fare qualcosa che in Italia non câera e sentivamo di doverlo fare da soli.
Rivolgersi ai bambini, o comunque ai giovani, allâinizio è stato un fatto per così dire naturale: in Italia erano i soli lettori di libri illustrati.
Oggi sono invece convinta che fare libri per bambini è una grandissima possibilità : quella di affrontare qualsiasi tema, anche il più spinoso. Intervenire nella produzione e nella formazione di cultura. Attraverso lâuso e la commistione di molteplici linguaggi, dalla poesia alla narrativa, dallâarte allâillustrazione e alla grafica, si può fornire ai ragazzi qualche piccola chiave per capire il mondo. Si può dar luogo a domande cruciali che il mondo degli adulti spesso è troppo vile da porsi.
Quanti titoli in un anno?
Fino ad oggi, dodici, tredici. Più le ristampe. Dal questâanno diventano quindici.
Spider, Il grande Alfredo, orecchio acerbo 2010
Nella scelta dei libri che pubblicate potreste individuare un filo conduttore? Eâ uno stile? Un messaggio? Unâidea? Un desiderio?
Oggi come allora sono convinta che i libri che pubblichiamo possano piacere solo ad alcuni bambini. Altri li ignoreranno, altri ancora non li capiranno. Ma fin dallâinizio ci siamo posti un problema pedagogico. La parola «pedagogia» deriva dal greco paidos «bambino» e ago «guidare, condurre, spingere avanti». Considero buoni libri quelli che fanno crescere, suscitano domande e aprono spazi di ricerca e immaginazione diversi, spingono avanti, per lâappunto. Grandi o bambini, meglio ancora se grandi e bambini. Lo stile non mi interessa, non è un problema che mi sono posta mai. Credo sia importante lâautenticità .
Quali caratteristiche deve avere un testo o unâillustrazione per sedurvi? Cosa è che vi fa dire: âquesto illustratore (autore) è per noiâ?
Quando mi costringe a pensare, oppure quando mi sorprende, o, ancora, quando mi incanta per la sua bellezza.
Nella situazione culturale e politica del vostro paese vi sentite inseriti in una rete che vi sostiene? Come la definireste? Quali sono i suoi fili principali?
Una rete? Se câè â ma ne dubito – forse è più saggio starne alla larga. Le reti non sono fatte per intrappolare? Meglio nuotare in profondità . Insieme ad altri, liberi.
Remy Charlip, Fortunatamente, orecchio acerbo editore 2011
Le co-edizioni: che politica avete di vendita e acquisto dei titoli? Preferite creare i vostri libri, venderli e/o comprarli dallâestero? Perché? Rispetto ai titoli che comprate e/o vendete ci sono differenze di accoglienza nei diversi mercati internazionali?
Proprio ora siamo arrivati a 100 titoli, e i libri tradotti da altri paesi sono 14, quindi, precisamente, il 14% del nostro catalogo. Sono pochi. Quindi, di sicuro preferiamo creare i nostri libri. Il motivo è innanzitutto lo stesso che ci ha spinto a dar vita alla casa editrice: la possibilità di far bene il nostro lavoro, e anche di rendere concrete le idee. E poi, è una vera felicità riuscire a farli tradurre in altri paesi. Non tanto per i soldi, che sono quasi sempre pochi. Per noi stessi, per gli autori e anche, ma solo un pochino, per orgoglio nazionale. Riuscire a fare coedizioni è invece fondamentale anche da un punto di vista economico, vuol dire abbassare di molto i costi di produzione perché quanto più è alta la tiratura, tanto più scende il costo di ogni singola copia. E questo vuol dire anche poter ridurre il prezzo di copertina. Tuttavia credo che un editore abbia anche il dovere di far conoscere nel proprio paese autori di altri paesi. Penso a Remy Charlip -è suo, fra lâaltro, il nostro centesimo titolo, âFortunatamenteâ-, Blex Bolex, Armin Greder, Atak, Benoît Jacques, Sergio Mora, Martin Jarrie e a molti altri che spero riusciremo a pubblicare. Per quanto riguarda lâultima parte della tua domanda, la risposta è sì, ci sono differenze grandi di accoglienza di un titolo fra un paese e lâaltro. Possono dipendere da vari fattori. Credo che quello decisivo sia la âforzaâ dellâeditore, ma altrettanto importante è il contesto culturale. à una banalità , ma forse vale la pena ripeterla. Viviamo in un paese in cui sulla cultura si è sempre investito poco, e quel poco oggi è diventato nulla. Naturale che un titolo âche sia un libro nato qui o altrove- nel nostro paese ha possibilità di riuscita di gran lunga inferiori a quelle della gran parte dei paesi occidentali.
âFabbricare cultura” nellâItalia di oggi, una missione, una sfida o una passione a perdere?
Dipende da quale cultura. Sempre, nel nostro lavoro, che lo si voglia o no, âsi fabbrica culturaâ. Io ne sento la responsabilità , so che i libri alle volte possono cambiare la visione del mondo, possono dar vita a -magari piccole- rivoluzioni. E quindi, probabilmente, è anche una sfida. Destinata a perdere? Ancora più probabile.
Una cosa che vi piace del vostro lavoro e una che non vi piace.
Mi piace il momento in cui arrivano le immagini. Ciò che accade fra scrittura e immagini non credo smetterà mai di darmi sorprese. ?Non mi piace vedere proposte di libri inaccettabili, ma ancor meno mi piace rifiutarle.

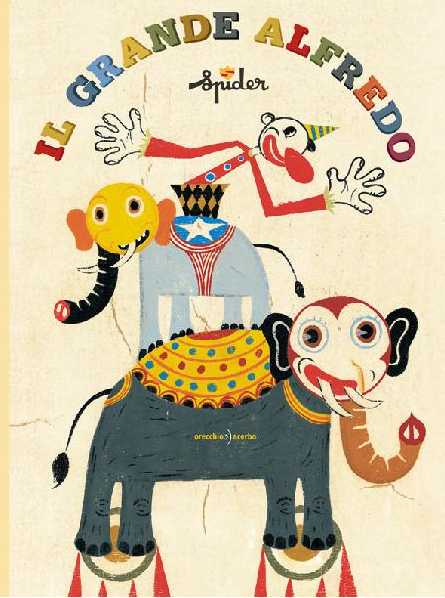
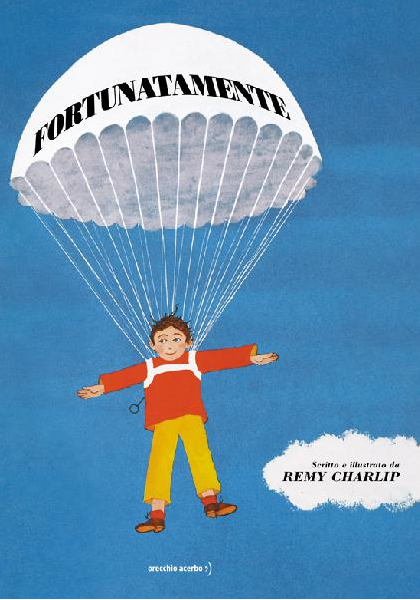
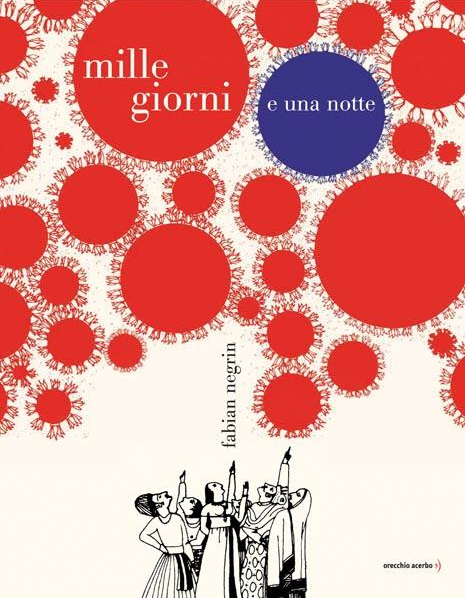

14 Febbraio, 2011 at 11:05
Cento di questi titoli!
14 Febbraio, 2011 at 18:57
sono davvero colpito da questa intervista, più di tutte le altre fatte. ne esce l’immagine che io stesso mi ero fatto di questa casa editrice: asciutta, poco interessata al politicamente corretto, con le idee molto chiare.
15 Febbraio, 2011 at 10:17
Questi ragazzi lavorano con un atteggiamento incoraggiante per tutti noi che lavoriamo in questo settore, sono davvero avanti.
Solo una cosa, non ho ben capito l’ultima frase, nè come si collega al discorso precedente.
Con “libri inaccettabili” intende cose come “la storia del coniglietto rosa che amava i confettti”?
15 Febbraio, 2011 at 10:59
Ogni volta che apro un libro di Orecchio acerbo so che quando lo chiuderò avrò conosciuto qualcosa o qualcuno di prezioso.
E si rafforza la mia convinzione di quanto l’albo illustrato ( di qualità !) sia insostituibile ed incomparabile.
Se, come nel “Libro sbilenco” , orecchio acerbo si impone rompendo gli schemi e le leggi che ingabbiano testo e illustrazione, al contempo c’e’ un “rigore” selettivo che fa di ogni suo libro un’opera d’arte. Credo che, per un illustratore come per uno scrittore, pubblicare con Orecchio sia davvero molto molto gratificante!
15 Febbraio, 2011 at 14:30
“Con âlibri inaccettabiliâ intende cose come âla storia del coniglietto rosa che amava i confetttiâ? “(IllaT)
Magari intendeva semplicemente brutti.
15 Febbraio, 2011 at 16:10
ciao! lavoro in libreria e devo ammettere che faccio fatica a vendere i libri di orecchio acerbo…ma quando ci riesco sono molto soddisfatta, mi sembra di contribuire ad allargare le menti dei miei clienti. esagerata?
No, perchè invece quando mi chiedono i libri della disney mi deprimo….e non li teniamo nemmeno in libreria!
21 Febbraio, 2011 at 11:55
“Oggi come allora sono convinta che i libri che pubblichiamo possano piacere solo ad alcuni bambini. Altri li ignoreranno, altri ancora non li capiranno. Ma fin dallâinizio ci siamo posti un problema pedagogico.”
Trovo questa frase cosi bella da essere commuovente.
7 Luglio, 2014 at 20:13
Mi è piacciuto molto leggere quest’intervista. Sono francese e ho conosciuto la casa editrice in una libreria di Milano. Studio la letteratura per bambini in Francia, all’università di Lille.
Una cosa nell’intervista mi sembra un po esagerata : quando Fausta Orecchio dice che “Allora, in Italia, di picture book non câera traccia.”
Mi sembra che dagli anni 70 in Italia si è svilupata una produzione di albi illustrati, grazie prima alla Emme che ha portato al pubblico i libri di Leo Lionni o di Maurice Sendak, poi ad autori italiani come Bruno Munari o ancora Iela ed Enzo Mari, o Roberto Innocenti, per parlare di quelli che conosco.
Poi anche la Corraini e i topipittori fanno albi illustrati.
Quindi mi sto chiedendo se è un modo di dire che non si faceva niente di interessante, o se la mia conoscenza dell’editoria in italia non è sufficiente per capire cosa ha voluto dire Fausta Orecchio ?
Spero che qualcuno mi potrà rispondere, è un soggetto che mi interessa molto visto che sto scrivendo una parte della mia tesina su l’editoria italiana.
7 Luglio, 2014 at 21:24
O allora forse fa la distinzione tra “albo illustrato” e “picture book” ?